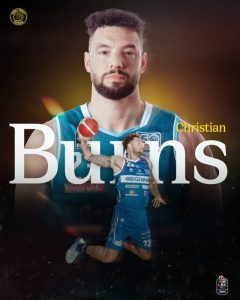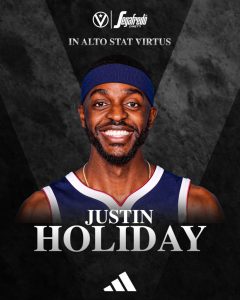Per quanto possibile, nell’era dei social networks, il tweet risuona fragoroso nella notte post gara  5 (“I’M A CHAMPION! I’M A CHAMPION!” Tutto maiuscolo n.d.r.). Normale, inevitabile, anche giusto, in fondo. Tanti, anzi molti quelli pronti a salire sul carro del vincitore, come lo scorso anno – al contrario – sono accorsi tutti a ballare sulla tomba del Re. Questo perchè ancora sfugge il concetto, non a tutti grazie a Dio, del singolo che vince o perde, della responsabilità soggettiva, nel bene e nel male. L’atleta ormai in qualsiasi sport, anche quelli individuali, non è più solo. C’è uno staff e una squadra anche dietro al nuotatore o al pugile, al velocista come al tennista. Moltiplicate tutto all’ennesima potenza quando parliamo di squadre, e nello specifico di team dello sport professionistico americano, che non è per forza un mondo sempre dorato, ma che di certo ha insegnato anche agli europei tante cose, soprattutto in materia di “circondare” gli atleti di vari personaggi, allenatori, trainer, medici, scout, e chi più ne ha più ne metta. Già questo fa capire come la vittoria di Miami non può essere ricondotta con semplicità da “faciloni del commento” solo alla grande serie giocata da Lebron James.
5 (“I’M A CHAMPION! I’M A CHAMPION!” Tutto maiuscolo n.d.r.). Normale, inevitabile, anche giusto, in fondo. Tanti, anzi molti quelli pronti a salire sul carro del vincitore, come lo scorso anno – al contrario – sono accorsi tutti a ballare sulla tomba del Re. Questo perchè ancora sfugge il concetto, non a tutti grazie a Dio, del singolo che vince o perde, della responsabilità soggettiva, nel bene e nel male. L’atleta ormai in qualsiasi sport, anche quelli individuali, non è più solo. C’è uno staff e una squadra anche dietro al nuotatore o al pugile, al velocista come al tennista. Moltiplicate tutto all’ennesima potenza quando parliamo di squadre, e nello specifico di team dello sport professionistico americano, che non è per forza un mondo sempre dorato, ma che di certo ha insegnato anche agli europei tante cose, soprattutto in materia di “circondare” gli atleti di vari personaggi, allenatori, trainer, medici, scout, e chi più ne ha più ne metta. Già questo fa capire come la vittoria di Miami non può essere ricondotta con semplicità da “faciloni del commento” solo alla grande serie giocata da Lebron James.
La vittoria per gli Heat è arrivata molto prima della sirena di gara 5. Sostanzialmente il primo mattone è stato messo nel momento in cui, con la famosa scenetta della decision, LBJ annunciava al mondo il suo approdo a South Beach, e dietro di lui il necessario (e determinante) accessorio conosciuto col nome di Chris Bosh. A molti detrattori non sarà sembrata vera l’occasione di ammirare tre spavaldi giovani afro-americani (e diciamolo) arricchiti e diventati improvvisamente antipatici, beffardi, burloni, vanitosi e…perdenti per tutta la parte di carriera trascorsa insieme. Wade comunque con la complicità dell’ultimo Shaq considerabile tale (correva l’anno di grazia 2006) il suo anello al dito se l’era già messo.
al mondo il suo approdo a South Beach, e dietro di lui il necessario (e determinante) accessorio conosciuto col nome di Chris Bosh. A molti detrattori non sarà sembrata vera l’occasione di ammirare tre spavaldi giovani afro-americani (e diciamolo) arricchiti e diventati improvvisamente antipatici, beffardi, burloni, vanitosi e…perdenti per tutta la parte di carriera trascorsa insieme. Wade comunque con la complicità dell’ultimo Shaq considerabile tale (correva l’anno di grazia 2006) il suo anello al dito se l’era già messo.
Nel mondo mediatico e globalizzato in cui viviamo che c’è di meglio di una soap opera dove alla fine i protagonisti perdono, in una sorta di remake cestistico de “Anche i ricchi piangono”, sconfitti dai paladini della giustizia di turno? Alla fine farebbe più ridere il Re che cade da cavallo che un’incoronazione monotona e scontata, non vi pare? E così è stato lo scorso anno, con il cavaliere biondo e tedesco a disarcionare il Re buffone, e a consegnare l’anello e la gloria alla sua compagnia fatta di veterani di mille battaglie, che “sicuramente” meritavano la vittoria più di questi tre cialtroni della Florida.
Ma in questa stagione il Re è tornato. I 15 giorni post sconfitta con i Mavs ci sono stati  ampiamente raccontati: Lebron rinchiuso in camera a meditare, a smaltire, per poi tornare. In fondo è anche questo che la gente vuole. Nel micro-cosmo di una singola stagione di pallacanestro James assomiglia molto a MJ, e non per i numeri e le statistiche (primo titolo a 28 anni come il più grande di sempre), ma proprio per l’idea romantica del ritorno, che Jordan ha assaporato e fatto vivere agli appassionati di tutto il mondo, con alterne fortune, ben due volte, dopo il baseball con altri tre titoli e dopo la noia, a Washington, per provare a se stesso che la natura si può sconfiggere…risposta sbagliata.
ampiamente raccontati: Lebron rinchiuso in camera a meditare, a smaltire, per poi tornare. In fondo è anche questo che la gente vuole. Nel micro-cosmo di una singola stagione di pallacanestro James assomiglia molto a MJ, e non per i numeri e le statistiche (primo titolo a 28 anni come il più grande di sempre), ma proprio per l’idea romantica del ritorno, che Jordan ha assaporato e fatto vivere agli appassionati di tutto il mondo, con alterne fortune, ben due volte, dopo il baseball con altri tre titoli e dopo la noia, a Washington, per provare a se stesso che la natura si può sconfiggere…risposta sbagliata.
Vittoria di squadra, dicevo, e se Miami voleva davvero portarsi a casa l’anello, se Lebron e soci volevano davvero quello che fino a quel momento avevano solo annusato, non potevano che passare da questa necessaria situazione. Mettersi nelle mani dei compagni, condividere con loro l’oggetto del gioco (la palla) e come direbbe coach Jackson: far sì che il valore complessivo della squadra sia maggiore della somma dei singoli. Il talento individuale…e chi l’ha mai criticato? Alcune scelte sbagliate, soluzioni non del tutto convincenti (tanti, troppi palleggi col cronometro che corre per poi tirare da fuori, tutti fermi, o la va o la spacca, ad esempio) questo sicuramente, ma che James e Wade su tutti siano giocatori fenomenali, beh penso sia palese anche per i meno attenti. La vittoria, perciò, è dovuta passare dal rientro di Chris Bosh e la sua nuova aggressività in campo, dalle giocate a volte scriteriate, sicuramente determinanti di ‘Rio Chalmers, dai tiri da tre di Shane Battier e di Mike Miller che, soprattutto in gara 5, quando onestamente è risultato incomprensibile come un uomo in quelle condizioni fisiche, dopo essersi trascinato costantemente per il campo, sia stato in grado di infilare le 7 triple che hanno scavato il definitivo solco tra gli Heat e i Thunder.
Lebron ha compiuto la sua missione. Quando tutto iniziò (copertina di Sport Illustrated dedicata a un liceale, non accadeva dai tempi in cui il portoricano Felipe Lopez incendiava le palestre delle high school di New York) con il roboante annuncio che sì, “The chosen one” era tra noi mortali, e il suo verbo sarebbe stato a breve diffuso tra le genti di tutto il pianeta, sapevamo già come sarebbe andata a finire. Il numero di anelli vinti, da qui alla conclusione della sua carriera, è e sarà solo un dettaglio, un insieme di circostanze, il riallinearsi dei pianeti e la benedizione degli dei del basket, scesa copiosa su Miami durante queste Finals. Ai Thunder non ne è andata bene una, se vogliamo appunto metterla su questioni legate al destino. Poi ci sono gli errori tecnico-tattici, di giocatori e staff tecnico (sport di squadra, ricordate?), la gioventù e quella che sembra una strada storicamente obbligatoria, fatta anche di brucianti sconfitte prima di coronare i propri sogni di gloria. Ma per quel che concerne il così detto “fattore C” ad Oklahoma City hanno segnato tutto, pronti a passare dalla cassa per riscuotere il dovuto in futuro. Futuro che è loro, non c’è dubbio, ma nella sfortuna ad esempio dei tanti palloni che girano sul ferro per poi uscire c’è anche una componente cestistica. Oh alla fine se guardiamo un canestro dall’alto capiamo facilmente come non sia così stretto, e che di palloni ce ne entrano anche due contemporaneamente. Questione di centimetri, forse anche millimetri, che soprattutto nei momenti decisivi aumentano, nella psiche di un giocatore inesperto, e fan sì che quella leggera differenza che c’è tra un tiro ben centrato e uno che approssimativamente si avvicina al bersaglio perfetto determini poi i sopra citati “in and out”.
high school di New York) con il roboante annuncio che sì, “The chosen one” era tra noi mortali, e il suo verbo sarebbe stato a breve diffuso tra le genti di tutto il pianeta, sapevamo già come sarebbe andata a finire. Il numero di anelli vinti, da qui alla conclusione della sua carriera, è e sarà solo un dettaglio, un insieme di circostanze, il riallinearsi dei pianeti e la benedizione degli dei del basket, scesa copiosa su Miami durante queste Finals. Ai Thunder non ne è andata bene una, se vogliamo appunto metterla su questioni legate al destino. Poi ci sono gli errori tecnico-tattici, di giocatori e staff tecnico (sport di squadra, ricordate?), la gioventù e quella che sembra una strada storicamente obbligatoria, fatta anche di brucianti sconfitte prima di coronare i propri sogni di gloria. Ma per quel che concerne il così detto “fattore C” ad Oklahoma City hanno segnato tutto, pronti a passare dalla cassa per riscuotere il dovuto in futuro. Futuro che è loro, non c’è dubbio, ma nella sfortuna ad esempio dei tanti palloni che girano sul ferro per poi uscire c’è anche una componente cestistica. Oh alla fine se guardiamo un canestro dall’alto capiamo facilmente come non sia così stretto, e che di palloni ce ne entrano anche due contemporaneamente. Questione di centimetri, forse anche millimetri, che soprattutto nei momenti decisivi aumentano, nella psiche di un giocatore inesperto, e fan sì che quella leggera differenza che c’è tra un tiro ben centrato e uno che approssimativamente si avvicina al bersaglio perfetto determini poi i sopra citati “in and out”.
Il Durant in lacrime dopo la sconfitta sta facendo emozionare più di un cuore. Il ragazzo  abbracciato ai genitori in cerca di consolazione è, sportivamente parlando e non, un quadro di vita che va giustamente sottolineato, nel mondo dei super-atleti, super-pagati, super…e basta! Ma finisce qui. Fai una lunga corsa dando tutto te stesso e quando allunghi la mano per prendere il premio questo ti scappa all’improvviso, proprio quando l’avevi accarezzato, nei tuoi sogni, avevi dato tutto per raggiungerlo e farlo tuo. Altri non avranno pianto (o forse sì…chi si è già dimenticato delle lacrime di Bosh la scorsa stagione, tanto ridicolizzate da televisioni e media, anche alle nostre latitudini?) ma l’abbattimento e la tristezza erano sempre tali e quali a quella di KD35. Per questo penso che guardare anche agli sconfitti sia giusto, senza esagerare al di là delle simpatie personali che sono umane e per questo consentite, ma non dimenticandosi che troppo spesso le stesse simpatie ci fanno fare dei distinguo ingiusti perchè comunque uno vince e uno perde, sarà sempre così perchè è la legge dello sport e se lo amiamo dobbiamo accettare i suoi verdetti.
abbracciato ai genitori in cerca di consolazione è, sportivamente parlando e non, un quadro di vita che va giustamente sottolineato, nel mondo dei super-atleti, super-pagati, super…e basta! Ma finisce qui. Fai una lunga corsa dando tutto te stesso e quando allunghi la mano per prendere il premio questo ti scappa all’improvviso, proprio quando l’avevi accarezzato, nei tuoi sogni, avevi dato tutto per raggiungerlo e farlo tuo. Altri non avranno pianto (o forse sì…chi si è già dimenticato delle lacrime di Bosh la scorsa stagione, tanto ridicolizzate da televisioni e media, anche alle nostre latitudini?) ma l’abbattimento e la tristezza erano sempre tali e quali a quella di KD35. Per questo penso che guardare anche agli sconfitti sia giusto, senza esagerare al di là delle simpatie personali che sono umane e per questo consentite, ma non dimenticandosi che troppo spesso le stesse simpatie ci fanno fare dei distinguo ingiusti perchè comunque uno vince e uno perde, sarà sempre così perchè è la legge dello sport e se lo amiamo dobbiamo accettare i suoi verdetti.
Verrà un tempo in cui anche i Thunder torneranno, presto se non prestissimo, avranno imparato e metabolizzato la lezione e se le regole salariali dell’NBA non faran sì che questo gruppo si sfaldi nel giro di pochi anni, beh di anelli ne arriveranno anche ad Oklahoma City, per la gioia di chi – sottoscritto incluso – ritiene quella di Westbrook, Harden e compagni una bellissima storia di basket che merita un diverso capitolo finale. Intanto si parla già di un altro (ennesimo) ritorno. Quello di Lebron James a Cleveland nel 2013. E cosa ci sarebbe di più bello del Re auto-esiliatosi che fa pace con la sua gente, col suo ex-owner, e riporta i talenti, ora finalmente rivelatisi in tutta la loro maestosità, a casa propria? Oh, Cinecittà ce l’abbiamo noi, ma Hollywood resta roba loro.
Andrea Pontremoli
@A_P_Official