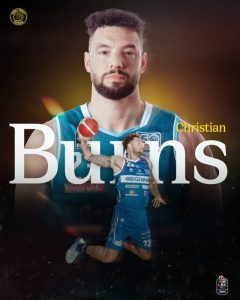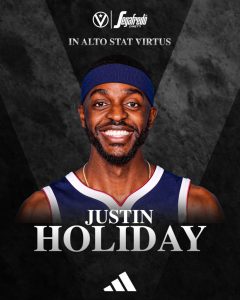Per chi non lo sapesse, la mia sfrenata passione per la pallacanestro a stelle e strisce nasce più di trent’anni fa per diretto interessamento di un signore di colore con la canotta giallo-viola numero 33 e con gli occhialini da gioco e grazie al folkloristico ma competente racconto di un altro signore molto, molto più piccolo del primo, dall’italiano perfetto, ma dallo smodato e scenografico accento yankee, con le sue telecronache la domenica mattina. E la passione non è stata continua, si è nutrita come ha potuto di MJ e, prima ancora, del Mozart dei canestri, che mi fece cambiare i colori del cuore, definitivamente, passando per due finals perse, un cambio di sede, scelte disastrose ed un faticosissimo rebuilding, il più difficile che la storia ricordi. Il tutto, tra le mille peripezie per guardare qualche spezzone di partita, in un mondo di videotapes e risultati al televideo che, per fortuna, non esiste più, sostituito da quella roba del tutto estranea alla mia generazione che risponde al nome di streaming che, insieme col mio nottambulismo vampiresco, ha aggravato il pathos fino a renderlo malattia, nel senso scientifico del termine. Malattia cronica senza speranza di guarigione.
In mezzo ai due mondi, frammenti di storia visti quando e come potevo: c’è stato Hakeem, c’è stato Manu il Fenomeno, e poi i Bad Boys e la loro pallacanestro zozza e ringhiosa e la faccia scanzonata e spaccona di White Chocolate incollata alla più sublime poesia in movimento.
E Melo… il suo uso dei piedi, il suo tiro in testa al mondo intero, il giro e tiro automatico che non ha bisogno di occhi. Era un basket dai 5 metri, quella terra di mezzo tra il mio primo amore e la NBA di oggi, in cui il senso del canestro era tutto, e pochi ne avevano quanto lui. Fisicità tanta, meno enfasi sull’atletismo e tanto senso del canestro: meno poesia, forse, più prosa, ma la medesima lirica di oggi. Forse anche di più, o forse è solo il manto nostalgico dei ricordi, non so.
Salomonicamente, era un altro basket. E Melo ne era il profeta.
Non mi ha mai fatto impazzire il gioco di Carmelo Anthony, tutto incentrato su sé stesso e sull’esaltazione di sé, accentratore come ne ricordo pochi altri in quello che io ho sempre amato, invece, in quanto sport di squadra, tanto più esaltante quanto più armoniosi i movimenti delle cinque note sul campo. E ai miei Nets, per di più vestendo la casacca blu e arancio, Melo ha sempre fatto tanto male. Ma per me e per i malati cronici come me, Melo è trasfigurato dall’aura dell’icona, e le icone non puoi contestarle, non puoi “odiarle”. Da discepolo di Naismith, puoi solo onorarle.
Senza contare che, come persona, grattando sotto la scorza della star piuttosto introversa ed arcigna, vale forse anche più che come giocatore. Voglio citare alcuni passi del libro di Idan Ravin, “A canestro”, dal capitolo nel quale il preparatore tecnico-atletico, tra i più richiesti dalle star NBA, parla del suo rapporto con Anthony. “Uno come Melo nasce una volta ogni generazione”…e poi prosegue raccontando l’uomo schivo e pronto a valorizzare anche le piccole cose nel prossimo, l’omone supertatuato che si reca all’allenamento con il passeggino del figlio e lo interrompe quando lo sente piangere, contraltare del bad guy che prende a pugni in campo Mardy Collins o insegue dopo la partita un trash talker rinomato come KG. Per poi chiudere con un aneddoto: un SMS di poche parole, come lui è, inviatogli da Melo immediatamente dopo aver conseguito il titolo di miglior marcatore della Lega: “tu ed io ce l’abbiamo fatta”!
Questo è Carmelo Anthony. Lo stesso che, dopo una sfolgorante carriera da superstar mai coronata da adeguati successi, dopo l’esperienza negativa di Oklahoma, ha sperimentato, per una volta, anche l’umiltà di accettare un contrattino a Houston e di rimettersi in gioco fino in fondo. Proprio con la squadra per la quale, per antonomasia, il gioco dai 5 metri, praticamente, è tabù…

Veniamo al presente. Melo non mette su la canotta rossa dall’otto novembre, in occasione della disfatta di Oklahoma City, in cui era stato parte integrante del disastro. Poi, desaparecido.
Come se non bastassero le illazioni sulla “malattia” che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare (diplomatica, secondo dietrologi e beninformati), ecco ESPN dare già per scontato che Anthony abbia sparato le sue ultime cartucce a Houston e che questo sia il pensiero diffuso nello spogliatoio dei Rockets. Dirigenza e star, secondo Wojnarowski, si sarebbero incontrati cercando un accordo, mai trovato, sul ruolo più giusto per Anthony nei Rockets di quest’anno e gli agenti del giocatore starebbero già sondando il mercato a 360°. Né sembra essere servita a molto l’intervista rilasciata dal GM Morey per gettare acqua sul fuoco, affermando che le voci che circolano sul conto di Melo sarebbero non veritiere e ingiuste: i più ritengono che si tratti solo di un doveroso ed elegante benservito, quantomeno per omaggiare la grandezza del personaggio e la disponibilità dimostrata firmando al minimo e accettando, per la prima volta, anche di uscire dalla panchina. Ma, a ben vedere, effettivamente, nel sistema-D’Antoni, con tutti i problemi scoperchiati in questo durissimo avvio di stagione, Melo sembra entrarci come un cavolo a merenda, confermando dubbi che da più parti erano stati sollevati fin da inizio stagione: la difficoltà di integrare l’icona più anacronistica in circolazione con il gioco più avveniristico della Lega.
Ed ora? C’è chi parla anche di ritiro…ci sta. Ma permettete, da parte di chi il Melo giocatore non lo ha mai amato, ma da discepolo ortodosso di James Naismith, di formulare un auspicio, una supplica agli dei del basket: che Carmelo Anthony trovi l’ultimo alloggio presso una squadra. E, mentre Wade e James twittano per difendere a spada tratta l’amico, il compagno del club degli élite players della decade passata, subito innescando un turbinio di rumors su ipotetici ricongiungimenti, io penso ai Jazz o ai Kings, come sistemi di gioco forse a lui più idonei.
Ma una squadra, una qualsiasi, che sappia valorizzare le sue immense doti e permettergli di chiudere da eroe, da icona. L’ultima icona di un basket che non c’è più.