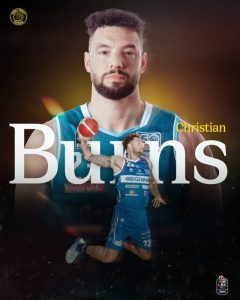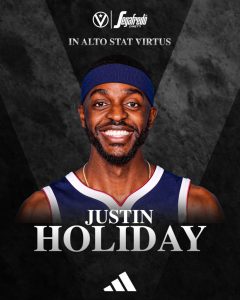Un giocatore come Steph Curry, un coach come Mike D’Antoni, un commissioner come David Stern. Premesso che nessuno dei tre ha nulla a che vedere con il tema che mi appresto ad affrontare, cos’hanno in comune figure tanto distanti fra loro? Probabilmente nulla, se non il fatto di aver segnato le rispettive epoche, tra loro parzialmente sovrapposte, ed aver cambiato non pelle, ma natura al Gioco (la maiuscola è maiestatis). Voglio dire: è pleonastico affermare che, guardando le partite oggi chi, come me, ha la sorte (fortunata o avversa, decidetelo voi) di aver visto gare NBA anche venti e trenta anni fa ha la netta sensazione di assistere, se non ad uno sport differente (iperbole che ho sempre trovato forzata ed inaccettabile), sicuramente ad uno stile di gioco profondamente diverso e questa evoluzione non è avvenuta in modo impalpabile, non ha avuto una lenta ma inesorabile progressione: ha proceduto a strappi, ed è innegabile che i personaggi succitati abbiano esercitato una forte spinta propulsiva, ciascuno nella sua specificità e più o meno volontariamente, in questo senso. Gli altri hanno dovuto adeguarsi: piaccia o non piaccia il modo in cui il basket è cambiato (a me piace, ma è altrettanto legittimo il parere opposto), si amino o si “odino” i suoi nuovi profeti, li si consideri o meno i GOAT nei rispettivi ruoli (per me non lo sono affatto), con loro occorre fare i conti e a loro occorre guardare con il dovuto rispetto.
 Non entrerò nel merito delle differenze tra il basket della mia gioventù e quello moderno, non è questo lo scopo del mio ragionamento. È invece pertinente, e ci porta dritti in argomento, che i cambiamenti abbiano inciso profondamente nella divisione dei compiti e, dunque, nella configurazione dei ruoli in campo, molto meno netti, molto più “liquidi”, così come mirabilmente sintetizzato da uno dei migliori mentori della new age, Brad Stevens.
Non entrerò nel merito delle differenze tra il basket della mia gioventù e quello moderno, non è questo lo scopo del mio ragionamento. È invece pertinente, e ci porta dritti in argomento, che i cambiamenti abbiano inciso profondamente nella divisione dei compiti e, dunque, nella configurazione dei ruoli in campo, molto meno netti, molto più “liquidi”, così come mirabilmente sintetizzato da uno dei migliori mentori della new age, Brad Stevens.
Senza dilungarci, avviciniamoci al cuore delle mie argomentazioni: ad esempio, la figura del playmaker (formato tascabile, veloce di mani e di piedi, con una visione di gioco superiore alla media e capace di creare per gli altri, prima che per sé) appare ormai vetusta, spazzata via, o quasi, dalla fisicità del basket moderno, dall’abuso di pick and roll e dalla plasticità del moderno difensore, abile a marcare su più ruoli svalutando, in tal modo, il principio del mismatch. Il risultato finale, la sintetizzo brutalmente e grezzamente, volutamente mettendo a fuoco solo uno degli innumerevoli cambiamenti in corso d’opera, è la necessità di accelerare le conclusioni, creare spazio, vantaggio, sfruttare ogni metro della metà campo avversaria e costruire nuove figure tecniche, nuovi ruoli, ibridi in grado di tenere, nella propria faretra, non solo le solite frecce, ma anche P38, kalashnikov e, all’occorrenza, perfino bazooka! Il play diviene point guard non solo e non tanto per esercizio semantico, né per sottigliezze tecniche, ma perché chi porta palla deve saper creare canestri, per gli altri e spesso soprattutto per sé e in tanti modi differenti, arrivare al ferro, assorbire i colpi ricevuti da avversari molto più grossi.
So che qualcuno di voi sta già pensando a prototipi presenti anche nel passato… ve la boccio subito, non vale: erano eccezioni, anomalie faunistiche, spettacolari animali esotici in un mare di normalità.
Fateci caso: oggi sono i giocatori tradizionali ad essere visti come specie in via d’estinzione, di cui augurarsi la salvezza ma alla cui sparizione ci si rassegna con malinconia ma con il fazzoletto bianco già pronto nella mano destra. Esempio eclatante: Melo. Eccezione altrettanto eclatante: mezza San Antonio, ma anche qui, non vale, perché ad orologeria: durerà finché il regista dell’amarcord sarà ancora il Sergio Leone del Basket, al secolo Gregg Popovich.
E, per quanto Magic fosse un play di 2,06, il che ha contribuito non poco a conferirgli l’immarcabilità che tutti noi (anziani) ricordiamo e gli ha permesso perfino di giocare da centro, anche questa ve la contesto: dopo di lui non è cambiato il mondo del basket, o almeno non quanto dopo Steph. Ancora dieci anni dopo di lui, il tiratore, libero ai sei metri dal ferro, che avesse fatto lo stepback per guadagnare la linea dei tre punti sarebbe stato preso per matto e panchinato: oggi è il segreto di pulcinella. Io continuo a preferire Magic come giocatore puro, ma la rilevanza storica del secondo resta superiore (pioggia di critiche in arrivo, ma è la mia opinione), così come si può preferire l’umanità di Ettore o di Tommaso Moro all’arroganza di Achille o di Carlo Marx, ma la storia l’hanno fatta i secondi, non i primi.
L’evoluzione del gioco, pertanto, iniziamo a vederla anche dalla comparsa, vorrei dire quasi dalla selezione darwiniana, di giocatori di stazza molto superiore (ali) in grado tanto di andare a canestro in tutti i modi, quanto di prendere palla direttamente a rimbalzo difensivo e costruire la manovra riducendo i tempi ed il numero dei passaggi per arrivare alla conclusione, di affondare il coast to coast o permettere, stando at the point, alle guardie di schierarsi implementando la pericolosità dal perimetro ed aprendo le difese come le acque di fronte a Mosè. E, se il prototipo della point forward è sua Maestà LeBron James, è anche vero che la figura si è evoluta conglobando ali sempre più “forti” (PF), in una commistione di ruoli e fisici sempre più atipica (Blake Griffin o, ancor più, Anthony Davis), prefigurando addirittura la comparsa di un animale mitologico ancor più assurdo, bestiale ma vagamente antropomorfo, francamente (ammettetelo anche voi) realisticamente inimmaginabile fino a pochi anni or sono (fatte salve sempre le belle eccezioni da giardino zoologico del passato): la point center (PC), il gigante con testa e mani del playmaker o, se preferite, il play “intrappolato” nel corpo di un pivot.
Era nell’aria, l’idea platonica e l’argilla grezza esistono da anni, a mio modesto parere gli sdoganatori definitivi sono venuti dal Vecchio Mondo (due fratelli spagnoli…), ma qui ed ora sta esplodendo in tutto il suo fragore grazie alla straordinaria stagione di Nikola Jokic, la più forte point center del mondo, di sempre, anche questa europea. Tanto dirompente la stagione e tanto forte lui da ricevere, da tanti, l’endorsement come candidato MVP, cosa che, per un centro, non era più di moda dai tempi di Shaq, o giù di lì. Anche perché, per inciso, Jokic sta reggendo i suoi Nuggets stabilmente in cima alla classifica della Western, in barba al Barba, a Steph, a LeBron, a RW e chi più ne ha, più ne metta, per una Conference tra le più ricche di sempre.
Qualche cifra, presente e passata, per capirci: dieci anni or sono, nella classifica dei primi cinquanta assistmen della Lega, figuravano sì e no isolate SF, e non certo nelle primissime posizioni. Ma ancora cinque stagioni fa, con LeBron già al top, con KD e Love già ampiamente in pista, i tre erano ancora bestie rare, essendo gli unici con oltre 4 apg di media, schiacciati tra 47 guardie. A meno di non considerare anche Iguodala, in realtà uno swingman molto fisicato, nel nostro conteggio (capite la difficoltà di definire bene certi ruoli?).
Oggi, e siamo solo a metà stagione, oltre ai succitati, sempre sul pezzo, e considerando solo i big men veri, ci sono anche Draymond Green, Blake Griffin, il sempreverde Marc Gasol, l’ex point guard troppo cresciuta Anthony Davis. E lui, Nikola Jokic, addirittura nono assoluto, perfettamente a suo agio in mezzo a tante point guards vere e proprie. La sua stagione recita, mentre scrivo, 19,2+10,2+7,6. Gli assist per gara sono addirittura 8,5 se consideriamo il solo mese di gennaio. E, dico, occhio, perché altri stanno emergendo: Karl Anthony Towns sembra finalmente deciso a sprigionare tutto il suo potenziale e, tra i suoi highlights, qualche assist da capogiro trova abituale dimora. Jusuf Nurkic, sottovalutatissimo artefice, come i più osannati Dame e CJ, del posto a tempo indeterminato dei Blazers ai vertici della Lega, a sua volta, pur in modo completamente diverso da Jokic, può considerarsi un interprete del nuovo ruolo in via di consolidamento. Ha saputo dimostrarlo tutto in una volta mettendo recentemente a segno una prestazione storica: 24+23+7+5+5, come mai nessun altro nella storia del Gioco!
E, se Marc Gasol e Al Holford rappresentano, a modo loro, i proto-esponenti del ruolo, Jokic il rivoluzionario che irrompe nella Storia definendone la rilevanza, non venite a dirmi che Joel Embiid, ad esempio, non ha le potenzialità per crescere anche at the point, o che Nikola (in nomen, omen…) Vucevic non abbia già le stimmate del big man in grado di costruire gioco per i compagni: altroché! E, ripeto, occhio, perché Luke Kornet (una rivelazione recente per voi, non per me che ho seguito la G-League lo scorso anno) e John Collins sono ragazzoni ancora adolescenti per il Gioco, ma con le carte in regola per incarnare, a loro volta e a modo loro, l’archetipo della mitologica figura della PC. Per inciso, stiamo ancora sulla banchina ad aspettare il ritorno di DMC..
C’è PC e PC… I centri moderni sono talmente divenuti parte integrante del gioco e della circolazione di palla, che le fila dei lunghi oggi definibili “moderni” si ingrossano a vista d’occhio, arricchendosi di new entry affluenti dal draft ma anche di veterani in grado di lavorare su sé stessi per migliorarsi. Non tutti possono essere definiti point center nell’accezione più purista del termine, ok…ma si dà il caso che io non sia un purista e che, invece, preferisca coinvolgere nella nuova definizione anche centri non propriamente abituati a giocare at the point, ma comunque in grado di gestire la palla e mettere i compagni in condizione di segnare in mille modi: con il tradizionale assist, così come con screen assist, dentro-fuori, give & go, alto-basso, apertura sul lato debole, penetra e scarica. Del resto, la stessa definizione di assist va evolvendosi…
Se si accetta la mia interpretazione del ruolo, indico tre tipi di point center, tenendo presente che, forse, sono anche pochi e che alcuni dei giocatori che indicherò potrebbero comodamente essere da qualche altro cultore del Gioco collocati in altra categoria (torna di nuovo a galla il concetto dei ruoli liquidi…):
– la forma più evoluta, di cui Jokic è senz’altro l’interprete più brillante, il centro che letteralmente sta at the point, gestisce palla, ama giocare fronte a canestro, oltre che in post e da centro tradizionale, sfrutta l’altezza per tirare o passare sulla testa del suo diretto marcatore, o l’abilità di mettere palla a terra e attaccare in terzo tempo se a seguirlo è il pari ruolo; magari, addirittura, guida il pick and roll da palleggiatore, invece che da bloccante. Un giocatore così può schiudere al suo coach un universo intero di soluzioni offensive difficilmente leggibili o arginabili per qualunque difesa;
– la forma più tradizionale (Nurkic o, per certi versi, Vucevic), che si muove per lo più come un centro old style, nei pressi del canestro o in post alto e, pur avendo stazza per vincere il duello fisico in avvicinamento, ha anche mano morbida tale da attuare le tre minacce, perché può prendere il tiro dal gomito, passare o mettere la palla a terra. La visione di gioco elevata a potenza consente di avere, così, un playmaker aggiunto da cui riaprire sul lato debole o assistere i tagli dei compagni, vanificando gli aiuti o permettendo agli esterni di aprire il campo. Valgono meno? Sono meno innovativi? Questione di opinioni, anche qui: Jusuf, ad esempio, difensivamente è superiore a quanti fin qui da me nominati, il che fa di lui un all-around player a tutto tondo. E può evolvere ancora…;
– la forma più eccentrica ed atipica, forse la più ricercata e rappresentata, ma non necessariamente la più efficace, quella che più propriamente potrebbe definirsi stretch five, il centro, cioè, abile nello show o nel pick & pop, immarcabile se ha nel carniere il tiro da tre punti. Brook Lopez la incarna, quest’anno, in modo tanto brillante (quasi 7 triple tentate per gara, il 37,6% di realizzazione: in pratica le cifre di LBJ lo scorso anno, tanto per capirci!) da essere, semplicemente, insieme ad Antetokounmpo e coach Budenholzer, la chiave della svolta Bucks, da crisalide divenuti farfalla anche grazie alla vocazione da stretch big di Brook ed alla sua incredibile performance dai 7,25. Incredibile, sì, ma solo per chi lo abbia seguito poco negli anni di Brooklyn (date un’occhiata ai numeri più vecchi di #stillawake #unmeseconinets e capirete che non è il nostro caso). Lopez, giunto a Milwaukee per quattro soldi (si fa per dire, eh…) ha semplicemente trasformato la sua scarsa propensione al rimbalzo, legata ad un atletismo sotto la media, in un’arma a proprio vantaggio, sfruttando la mano morbida per implementare le doti nel trattamento della palla, anomale per un centro della sua corporatura, estendendo la sua gittata e assistendo i compagni dal post. A Brooklyn, nell’ultima delle sue nove stagioni, non solo aveva già mostrato questo tiro, ma viaggiava anche come secondo assistman di squadra! Chi vi dice che non torni in voga anche ai Bucks?
L’evoluzione del Gioco è come quella della specie: una volta mutato il DNA in modo vantaggioso per dominare l’habitat, non si torna indietro. Già quest’anno svettano, finora, due realtà che ruotano intorno ai propri centri moderni (Giannis, mi perdonerai la forzatura, ma sei un ragazzo intelligente, saprai anche quando è il momento di cedere la scena ai tuoi gregari!). Non è dato prevedere se sapranno portare fino in fondo la loro missione, ma sono pronto a scommettere che stiamo vivendo, grazie alle point centers, un altro cambiamento epocale, con biglietto di sola andata. E voi?