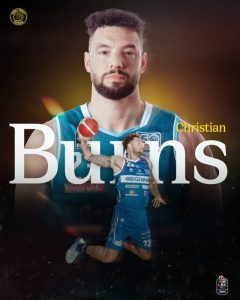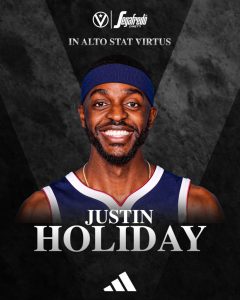Ci sono eroi che cambiano la percezione della passione sportiva, che entrano nell’immaginario collettivo appena si nomina la palla a spicchi, come per riflesso condizionato.
E ci sono tragedie di cui non vorremmo mai leggere. Alle quali non riesci a credere, che ti proiettano in una dimensione surreale in cui credi, speri, preghi di vivere un incubo. Di cui vorremmo solo piangere.
Ecco: questi eroi e queste tragedie non dovrebbero mai trovarsi nello stesso testo. Non in un mondo giusto e ideale.
Purtroppo tendiamo tutti a dimenticare che anche Kobe Bryant non era puro spirito, non era la semplice incarnazione della mamba mentality, né pura estetica del movimento, quel movimento di giro e tiro in fade away e in faccia al mondo intero che nessuno dimenticherà mai.
NO. KOBE era un uomo, come noi. E come noi fragile e caduco. Ecco perché, dopo dieci minuti, quando le conferme arrivano dalle principali testate mondiali, rimetti i piedi nella realtà e capisci che è tutto vero, che quell’elicottero in fiamme era il suo e non ce lo restituirà mai. Lui come gli altri passeggeri tra cui, tragedia nella tragedia la figlia tredicenne, Gianna.
Vedi com’è il basket. Vedi com’è la vita. Proprio ieri applaudivamo un’altra leggenda, LeBron James, per averlo scavalcato al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre. Sorridevamo dei suoi tweet di congratulazioni, perché la mamba mentality è ormai carne viva in Nba ed è fatta per essere trasmessa, non per cristallizzarsi in un record.
Così, per provare a mettere in parole l’emozione personale, sono certo che ognuno di voi stia adesso vedendo un’immagine di Kobe, prima di tutto specchiandosi nei propri ricordi: beh, la mia è quella di me stesso, che metto la sveglia all’alba per assistere, con sgomento e incredulità (di tutt’altra natura, rispetto a stasera), all’ultima partita di Kobe, tre anni fa.
Il mio, il nostro Kobe: un coacervo di ricordi, quei movimenti che tutti noi abbiamo una volta nella vita provato goffamente a imitare sul campetto sotto casa. Una inutile partita di regular season dei suoi Lakers, una delle partite più seguite in tutto il mondo. Perché tutti, chi dallo Staples, chi, come me, dal divano di casa sua, tutti noi che amiamo questo gioco meraviglioso anche grazie a lui, e come lui pochi altri, ci sentivamo in dovere di porgergli l’ultimo saluto. Quello era un saluto di commozione felice, onorati com’eravamo, di essere testimoni della Storia.
“Mamba is out” chiosó lui quella notte, persino nella commozione degli osanna del suo popolo, era presente la sua consapevolezza mai tracotante, la fierezza giusta.
E mi fermo qui perché al ricordo commosso voglio che segua il silenzio: non mi va di tornare indietro alle Finals di inizio secolo, quando, in un misto di astio impotente e ammirazione, lo vidi (in differita, a quei tempi…) fare a pezzi i miei sogni di tifoso con un secco 4-0. Non oggi.
Mamba is out, sì, ma il suo spirito vivrà per sempre nelle arene come sui campetti.
Come su quel campetto dove ho sparato le mie ultime cartucce contro un canestro. E dove campeggia, oggi tristemente, un graffiti con la sua gigantografia: più grande di me, più grande di tutti.