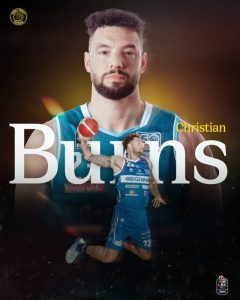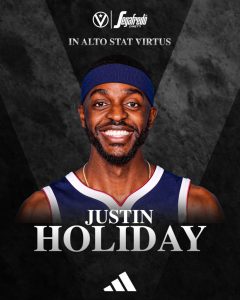C’era una volta Michael Jordan. Ora c’è LeBron James. Punto.
Potremmo chiuderla qui, perché nessun altro giocatore nella storia del basket mondiale è neppure lontanamente avvicinabile a questi due nomi per classe ed effetto dirompente nell’immaginario collettivo. A seguire, forse, a rispettosa distanza, i vari losangelini, da Kareem a Kobe, passando per Magic e Shaq, i quali hanno sì, segnato le rispettive epoche, lucrando anche della cassa di risonanza loro conferita dalla casacca gialloviola, ma soprattutto tanto bravi da contribuire ad alimentarla; tuttavia sono una spanna sotto. Sarà anche una mia opinione, ma non scherziamo, ragazzi…
E già sento piovermi addosso le peggiori critiche sulle mie dimenticanze e/o sulla mia parzialità: e Akeem? E Larry Bird? E i giganti del passato, tipo Jerry West o Wilt Chamberlain, l’uomo dai 100 punti? Alzo le mani e mi arrendo all’altisonanza di questi e altri nomi (Iverson, Miller, Rodman, sir Charles…) ma io tiro dritto: nessuno si avvicina ai succitati.
E, soprattutto, tenetevi le cartucce per il prosieguo del mio articolo, perché non è di questo che parleremo: intendo darvi in pasto motivi ben più validi per scaricarmi addosso il vostro arsenale!
 Da quando frequento i social non è passato giorno in cui non abbia letto qualcosa in merito all’eterna diatriba: più forte MJ o LBJ? Qualcuno con dovizia di particolari, altri basandosi sulle statistiche, altri ancora su più o meno lucide letture del gioco e, infine, una miriade di commenti diversamente interessanti o intelligenti, ma la verità è una sola, un po’ come per il dualismo Maradona-Pelè: chissenefrega?!? Ogni epoca ha il suo modo di giocare, il basket in questi anni ha cambiato pelle e gli skills oggi richiesti non sono gli stessi di venti o trenta anni fa, per cui è semplicemente insensato ogni paragone: ciascuno si tenga le sue preferenze.
Da quando frequento i social non è passato giorno in cui non abbia letto qualcosa in merito all’eterna diatriba: più forte MJ o LBJ? Qualcuno con dovizia di particolari, altri basandosi sulle statistiche, altri ancora su più o meno lucide letture del gioco e, infine, una miriade di commenti diversamente interessanti o intelligenti, ma la verità è una sola, un po’ come per il dualismo Maradona-Pelè: chissenefrega?!? Ogni epoca ha il suo modo di giocare, il basket in questi anni ha cambiato pelle e gli skills oggi richiesti non sono gli stessi di venti o trenta anni fa, per cui è semplicemente insensato ogni paragone: ciascuno si tenga le sue preferenze.
Io che li ho visti giocare entrambi (LeBron di più grazie alla potenza dei media) preferisco LeBron e non da oggi. MJ era semplicemente geniale, oltre che un grande atleta: non ha solo marchiato un epoca, ha semplicemente diviso la Storia in un prima e un dopo. Ma LeBron ha portato l’idea del giocatore di pallacanestro, atletismo e onnipotenza offensiva ad un altro livello, al di là delle cifre. Forse, paradossalmente, proprio perché molto meno vincente di Jordan, mi ispira di più, così come Ettore rispetto ad Achille, acquista una dimensione umana e non divina per scendere all’inferno e risalirne per sfidare gli dei e le scienze numeriche e divenire più grande di loro, umano e non più umano, insieme.
Il lavoro incessante in palestra e l’impegno dell’uomo fuori dal parquet fanno di lui un campione sotto tutti gli aspetti, lo rendono speciale anche agli occhi di chi, come me, non ha mai nutrito particolare affetto per i fanatici cultori del proprio corpo né per i filantropi, comodi donatori di ricchezze dal calduccio della propria poltrona dorata e per lo più a scopo di vernissage personale: un lifting sociale.
Una visione certo romantica, forse romanzata, sicuramente demodé, priva com’è di riferimenti algoritmici, e, chissà, anche destinata a cambiare quando, fatalmente, il tempo farà il suo corso e LeBron finirà nell’album dei ricordi accanto a Michael Jordan, in un Pantheon che guarda perfino l’Olimpo dall’alto, aspettando sobriamente the next one (Zion?).
Il punto, tuttavia, è un altro: io LBJ nella mia squadra del cuore non lo vorrei mai e prego gli dei del basket di risparmiarmi una simile sciagura!
Detto che sarò agevolmente accontentato (tengo per i Nets, non corro pericoli), prima di far fuoco concedetemi, come ultimo desiderio, di spiegare ai bambini portati ad assistere all’esecuzione perché io abbia peccato, maturato la mia convinzione da cui recederò solo quando qualcuno mi convincerà del contrario: adoro guardar giocare LeBron, è uno spettacolo senza pari, ma lasciate che me lo gusti da osservatore neutrale.
Non mi piace confidare in un uomo solo, se devo recuperare uno svantaggio o giocarmi la partita decisiva. Non mi piace che tutti i ragazzi del roster, talentuosi o meno, debbano essere asserviti al Re, lasciare la palla nelle sue mani e servire solo a creargli spazio o, al più, fornirgli alternative, esaltarlo con i suoi assist.
Ma questa è l’ultima delle mie perplessità.
Il Re ha sconfitto chiunque, perfino la formidabile macchina dei Warriors, praticamente da solo, o quasi. Eppure non è un vincente: sono più le finals perse che quelle vinte: 3-6 il suo record, dopo averle buscate da San Antonio, Dallas e, soprattutto, dalla rivale del millennio, i Golden State Warriors, appunto. A Cleveland ci è riuscito una volta sola, con uno sforzo epico, trovando scorciatoie, sentieri, mulattiere percorribili solo per lui. Quando ha capito che oltre il miracolo non era possibile andare, ha lasciato la città in macerie, per ben due volte. Non molto diversamente è andata in Florida, dove ancora oggi (complice un Riley non proprio lucidissimo nelle scelte) si naviga un po’ a vista non sapendo bene che strada prendere. Lì, però, se non altro, si è messo al dito due anelli, ma, per farlo, ha messo insieme il primo trio delle meraviglie con lo sfortunato Bosh e, soprattutto, il miglior Dwyane Wade. Capite? Per vincere ha inventato il concetto di superteam, di instant team, cioè di squadrone creato dal nulla. Si è abbassato il salario, ha cambiato l’idea stessa di mercato. Oggi, guarda caso, la sua creatura gli si è rivoltata contro, il nemico ha imparato e sublimato… Ha avuto carta bianca, fatto e disfatto squadre, tutto per soddisfare la sua fame.
Finito il lavoro, addio…Si torna a casa.

Legittimo, soprattutto nel secondo addio alla città natale, scegliere di mollare e provare a vincere altrove: i titoli in cerniere non rendono onore alla sua classe ed ha ancora i mezzi tecnici e fisici per provarci almeno altre tre, forse quattro volte, secondo me. Ma ora è ai Lakers e l’andazzo, a giudicare da quanto visto finora, non è molto diverso dal solito.
Ricapitoliamo: il suo carisma e il suo peso specifico sono tali da fare di lui non solo il legittimo leader incontrastato in campo, ma anche il coach, il GM e il sommo giudice, nonostante di fronte a lui, dall’altra parte della scrivania, sieda un certo Magic Johnson, non certo un pischello cui difettino personalità o influenza. Eppure, circondato di belle promesse, succede che: la squadra stenta a carburare e subito inizia a scricchiolare la panchina di Walton. Poi inizia a girare tutto come si deve, i gialloviola risalgono fino alla quarta posizione e paiono un fiume in piena e si sente parlare solo di lui e delle sue cifre. Eppure la squadra ha acquisito una fisionomia ben precisa: certo, ruota tutto intorno a lui e in funzione di lui, ma Ball difende in modo sopraffino, Kuzma si dimostra un secondo violino credibile, Ingram ingrana e difende su più posizioni, Chandler arriva e sfoggia prestazioni da centro ora notevoli, decide partite, perfino, giocando da battitore libero e, insomma, i lacustri hanno un’anima ed un habitus da longball che difende e si realizza e si scopre anche bello quando corre in transizione, quasi irresistibile.
Poi arriva la notte di Natale, il re si tocca l’inguine e addio… Un mese da record negativo e scusate se, dopo aver disegnato un bello schizzo su precisa commissione sua, ora Walton, il povero malcapitato di turno (come anche, prima di lui, Blatt e Lue, peraltro ancora disoccupato) non è stato capace, in una notte, di cancellare tutto e ridisegnare da capo su soggetto completamente diverso! Anzi, ora finisce anche bullizzato nello spogliatoio da McGee e Beasley (si diceva anche Stephenson, ma se n’è chiamato fuori sdegnato), due cervelloni arcinoti, eh! Chiamati a Los Angeles proprio da LeBron, eh! Da qui la sentenza: la pazienza del monarca è già finita, Lui con questi non può vincere, si vada subito alla caccia grossa! Serve una stella da affiancargli e ora, nel mirino, c’è Anthony Davis…
 Cavoli! Ma ve la immaginate una coppia del genere?!? Un tale combinato di potenza e classe, insieme, come mai nella storia del Gioco: probabilmente, il sogno di chiunque! Fra vent’anni potrò raccontare ai miei nipotini di averli visti giocare insieme, recitare il proverbiale “io c’ero!” suscitando un lampo di malcelata invidia nei loro occhi sgranati mentre le mie guance canute si segnano con il rivolo della lacrima… E non è finita qui: ci sarà ancora spazio salariale per un’altra star, l’estate prossima, e chi non sarebbe già con le valigie in mano, sapendo che il Re e il Monociglio stanno reggendo per te i battenti del portone dello Staples? Klay Thompson (non lo nascondo: il mio giocatore preferito!) ha già alzato la manina, entusiasta.
Cavoli! Ma ve la immaginate una coppia del genere?!? Un tale combinato di potenza e classe, insieme, come mai nella storia del Gioco: probabilmente, il sogno di chiunque! Fra vent’anni potrò raccontare ai miei nipotini di averli visti giocare insieme, recitare il proverbiale “io c’ero!” suscitando un lampo di malcelata invidia nei loro occhi sgranati mentre le mie guance canute si segnano con il rivolo della lacrima… E non è finita qui: ci sarà ancora spazio salariale per un’altra star, l’estate prossima, e chi non sarebbe già con le valigie in mano, sapendo che il Re e il Monociglio stanno reggendo per te i battenti del portone dello Staples? Klay Thompson (non lo nascondo: il mio giocatore preferito!) ha già alzato la manina, entusiasta.
Fantastico, direte voi! Fantastico, fa eco il web in modo pressoché unanime, come un Moloch che fiuta la preda, con la bava alla bocca. Dov’è, dunque, il problema? C’è un’altra faccia della medaglia?
Si, c’è. Perché I gloriosi Lakers sono fuori dai playoff da cinque stagioni, hanno fatto cose e giocato stagioni che nessuno a Los Angeles ricordava, regalato la palma di prima squadra cittadina agli ambiziosi Clippers, gli sfigati di sempre, i nerd alla riscossa, dato il doveroso addio a Kobe, il monumento vivente, pazientemente fatto mercato per dare spazio e squadra a Lonzo Ball, rinunciando alla pazienza dovuta a un tipino come D’Angelo Russell, chiamato un giocatore atipico ma dal talento naturale come Ingram, una delle più belle promesse ancora non mantenute. Hanno raccolto diamanti nella melma delle scelte più base al draft con Hart e, soprattutto Kuzma. I nobili Lakers hanno cambiato anima e pelle, si sono sporcati le mani nel fango del tanking, hanno costruito un progetto. Quindi lo hanno donato al Re. E questi, alla prima occasione, dopo mezza stagione così, è subito pronto a metterli sul primo volo per New Orleans per mettersi affianco una star che lo aiuti a vincere…
Ora mi direte che lo sport pro, NBA in testa, lo si gioca per vincere, non per impartire lezioni morali e neppure per mettere in piedi una scuola basket con la speranza di scovare il talentino del futuro. Quindi, se il Re leone promette vittorie, ci si sottomette a lui e si fa branco. Ci sto, ci sono sempre stato. È il mio Gioco, il mio campionato da più di trent’anni, ormai l’ho capita, la lezione.
 Solo, due domande: dopo averci messo la faccia e le parole grosse, a Magic va bene cancellare tutto ciò che ha messo in piedi dall’addio di Kobe ad oggi? E, quando il Re abdicherà (perché presto o tardi, fatalmente, arriverà anche quel momento), le scelte saranno andate altrove, i giovani talenti anche e le star chiamate dal re diverranno sempre più i sofferenti e desiderose di vincere cambiando aria, allo Staples Center, i cui battenti si aprivano e si chiudevano a comando automatico azionato dalla voce di LeBron, cosa resterà, se non le solite macerie? Come a Cleveland, soprattutto. Come, in parte, anche a Miami, ove possono, sì, consolarsi guardando la bacheca, ma pure ci vorranno anni, lustri (decenni?) per tornare a quei livelli.
Solo, due domande: dopo averci messo la faccia e le parole grosse, a Magic va bene cancellare tutto ciò che ha messo in piedi dall’addio di Kobe ad oggi? E, quando il Re abdicherà (perché presto o tardi, fatalmente, arriverà anche quel momento), le scelte saranno andate altrove, i giovani talenti anche e le star chiamate dal re diverranno sempre più i sofferenti e desiderose di vincere cambiando aria, allo Staples Center, i cui battenti si aprivano e si chiudevano a comando automatico azionato dalla voce di LeBron, cosa resterà, se non le solite macerie? Come a Cleveland, soprattutto. Come, in parte, anche a Miami, ove possono, sì, consolarsi guardando la bacheca, ma pure ci vorranno anni, lustri (decenni?) per tornare a quei livelli.
Magari, poi, domani la trade per AD non va in porto, oppure NOLA accetta la prima mezza offerta ricevuta (Ball, Zubac, Rondo, Beasley e la prima scelta) e tutto il mio ragionamento rotola nel cassetto. Io, però, non credo che le cose andranno così. Il Re Leone ha fame, la sua nuova città ne ha più di lui e alla fine prevarrà l’istinto predatorio del felino. E al diavolo i cuccioli! Se le vittorie arriveranno, magari non quest’anno, ma il prossimo si, avrà di nuovo avuto ragione lui. E a dopodomani ci si penserà domani…
Io, però, resto della mia: dove sto tirando su un bel giardino, preferisco coltivarlo con le mie mani, vederlo crescere, fare i giusti innesti e poi impreziosirlo con la pianta da concorso. Ci vorrà un po’ di più, ma i successi, se il giardiniere ha il pollice del colore giusto, presto o tardi arrivano.
Non mi metto nel giardino di casa una sequoia le cui radici tolgono acqua e concime a tutto il resto… Perché anche le sequoie hanno un principio e una fine ed io, dopo, non voglio ritrovarmi con un deserto intorno!
No: adoro LeBron, ma io, nella mia squadra, non ce lo voglio!