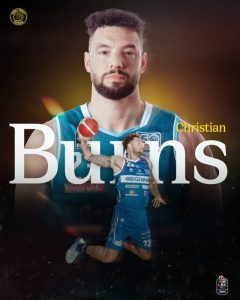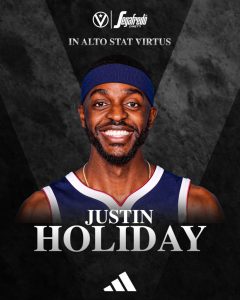C’è un giocatore in NBA che ha attaccato il ferro meglio di LeBron James, tirato da tre meglio di Kyle Korver, messo insieme statistiche avanzate da leader assoluto, messo in riga tutte le All Star. Quel giocatore oggi calca i parquet cinesi con #TeamUSA, a caccia del terzo oro consecutivo, ma il suo nome, fino a febbraio scorso, era noto solo ai più incalliti appassionati di basket e ben pochi hanno avuto il piacere di seguirne il percorso. Motivo? Gioca nella franchigia fino a poche settimane fa più vituperata e meno seguita della Lega: i Brooklyn Nets. Meno seguita da tutti, fuorché da All-Around.net, of course. Quel giocatore si chiama Joe Harris.
Su Joe Harris si scrive decisamente troppo poco, in Italia come in America. Se venisse istituito un premio come MUP (most underrated player) in NBA, lui sarebbe il candidato ideale.
Nome più adatto ad un passaporto falso che ad una star sportiva, Joe ha colto al balzo le occasioni che il Fato gli ha messo sulla strada, quasi a compensarlo delle iniziali sfortune, e ogni volta ha saputo trasformarle in oro colato.

Si è fatto le ossa nelle high school sotto la guida di un coach speciale, omonimo: il padre. Reclutato dai Virginia Cavaliers, arriva, nell’anno da Junior, a livelli da quintetto All-ACC. Non è un college di primissimo piano, il suo, e lui ha fama di essere un tiratore specialista e poco altro (40% dall’arco comodo), per cui non va oltre la 33esima nel 2014, chiamato dai Cavs ancora orfani del primo LBJ. La speranza di trovare spazi, però, dura tra Natale e Santo Stefano: prima il gran ritorno, poi la trade che porta alla corte del re Shumpert e JR, gli sbarrano l’accesso al parquet, per cui vedrà molto Canton (in quella che, all’epoca, si chiamava ancora D-League) e poco Cleveland, finché (gennaio 2016) un intervento al piede destro non lo mette fuori gioco e fuori dai giochi, tanto in Ohio (tradato), quanto ad Orlando (subito tagliato). Chi crederà in lui, se non Sean Marks, il cacciatore, per passione o per necessità, dei talenti i più nascosti?
A Brooklyn arriva nell’anno zero, nella prima offseason targata Marks e Atkinson, a tappare il buco spianato dal gran rifiuto di Miami (Tyler Johnson) e (temporaneamente) di Portland (Allen Crabbe). Sembra un rimedio posticcio, una scelta di ripiego, questo ragazzone al minimo salariale, invece, nel primo anno, brilla nella specialità della casa (comodo 38% dall’arco); poi, guadagnata la fiducia dell’ambiente, sforna una seconda stagione da lustrarsi gli occhi: stabilmente oltre il 40% da tre, dopo la sosta per l’ASG addirittura primo assoluto nella Lega col 47%, sorprende tutti per intelligenza, efficienza, consistenza, sfoderando un drive pazzesco (quanti sanno del suo irreale 62% negli attacchi al ferro, superiore perfino a Sua Maestà James?) e spirito di sacrificio in difesa (lo abbiamo visto spendersi sui cambi in post contro gente che gli dava 20 cm). Quasi un “triple threat”, quasi un 3&D, Joe ha solo 28 anni (li compirà in Cina) e, lo scorso anno, ne segnalavamo gli ulteriori margini di crescita, forte com’era di una incrollabile etica del lavoro.
E, infatti, non ha mai deluso, non ha mai smesso di crescere e sviluppare i suoi skills, Joe, grazie anche ad uno staff tecnico, quello dei Nets, all-in nella raffinazione dei diamanti grezzi come lui. Harris si guadagna il posto da titolare in pianta pressoché stabile, implementa i minuti in campo (30 per allacciata di scarpe) e, nonostante questo, migliora tutte le sue voci statistiche, in modo tanto lineare nel corso dei suoi tre anni a Brooklyn, da non lasciare spazio a dubbi: nulla è frutto del caso e tutto è farina del suo sacco e delle sue doti. Migliora in percentuale da 2 e da 3 punti (irreale 47% dai 7,25 come media stagionale), ma anche alle voci rimbalzi, assist, At/TO, e riesce a crescere ulteriormente perfino nelle voci statistiche avanzate più significative per reale efficienza al tiro: risulterà il miglior esterno della Lega per true shooting percentage, con un clamoroso 64,5%, lasciandosi alle spalle perfino Steph Curry.
La chiamata al Three Point Contest, all’All Star Game di Charlotte, arriva di nuovo quasi per caso, per via delle defezioni altrui e solo all’ultimo momento (altra occasione da cogliere), eppure suona quasi come un approdo naturale; la sua vittoria, bellissima, non stupisce quasi più nessuno, se non gli appassionati più tiepidi ed occasionali. E, finalmente, piovuto su cotanto palcoscenico, il mondo si accorge di lui.
La sua stella risulterà solo transitoriamente opacata dalle scialbe prove balistiche ai playoff: era alla prima apparizione e i Sixers gli hanno riservato un trattamento speciale. Andrà meglio la prossima volta…
Gran parte della sua parabola ancora ascendente la deve al notevole QI cestistico, che gli ha permesso di mettere a frutto il terrore instillato in qualsiasi difesa, per sviluppare una insospettata capacità di andare oltre lo spot up e il catch and shoot, mettere la palla a terra, aggredire il ferro: solo chi lo ha visto giocare poco spesso può sorprendersi, ad esempio, del fatto che Joe “buckets” (questo, il suo motivatissimo nickname) abbia equilibrato progressivamente le conclusioni da due e da tre punti: il rapporto era 39-61 nella prima stagione a Brooklyn, fino ad arrivare quasi al 49% delle proprie conclusioni dall’interno dell’arco, nel corso dell’ultima regular season.
Pur non dotato di lunghe leve, la sua attitudine difensiva inizia a farsi notare: ha il fisico per reggere i contatti, passare sui blocchi, non mollare di un centimetro il suo uomo. Sembrerebbe questa la qualità nascosta che più ha colpito Gregg Popovich: reclutato nel Select Team, per fare da sparring partner alla prima squadra, ha grattato giorno per giorno il muro che lo divideva dal successo, finché, ancora una volta, la dea bendata lo ha baciato: ha lavorato e atteso diligentemente il suo momento, poi le tante defezioni lo hanno catapultato nella selezione dei 12 e lui ha saputo, ancora una volta, capitalizzare l’opportunità concessagli. Il Pop lo ha testato, studiato, provato in tutte le amichevoli disputate, poi, dall’alto della sua sagacia tecnica, ha capito cosa chiedere a Joe e, nella prima assoluta, lo ha gettato nella mischia per quasi 20′, il più delle volte proprio per sopperire alle amnesie difensive di Tatum. E Joe ha ripagato in moneta sonante: migliore in campo per plus/minus (+19) e 9 punti, manco a dirlo, con 2/3 dalla linea dei tre punti…
Il nostro si è ripetuto, come sempre ha saputo fare in carriera, nella seconda uscita, in quella rocambolesca e fortunosa vittoria strappata alla Turchia, mettendo a referto 11 punti e 5 carambole, due palle rubate e ancora 2/3 dall’arco: canestri e giocate nei momenti decisivi, per cercare di invertire l’inerzia. Anche Popovich e la nazionale americana, ormai, non possono più fare a meno di lui…
Occhio a Joe Harris, perché la stella di Brooklyn non ha nessuna intenzione di smettere di stupire!