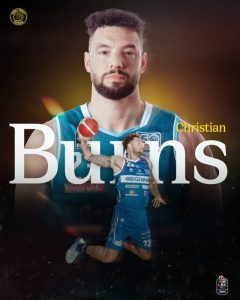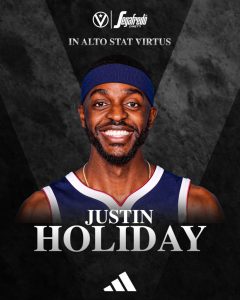Addormentarsi allenatore dell’anno, svegliarsi disoccupato. Cose americane, d’accordo, ma lo stupore fa a gara con lo sconcerto: è di queste ore la notizia del licenziamento di coach Dwane Casey ad opera dei Toronto Raptors, ed è la più kafkiana e paradossale delle situazioni, se si pensa che lo stesso coach aveva, solo poche ore prima, ricevuto l’investitura di COY da parte dei colleghi! Un amaro finale, davvero, per il pluriennale capo della panchina canadese, fresco di sweep subito per mano di King James in semifinale di Conference…
Potremmo liquidare la vicenda giudicando la sua parabola canadese al capolinea, dopo sette anni di infruttuosi tentativi di andare oltre le semifinali. Potremmo fare filosofia spicciola, affermando (non a torto) che anche questo fa parte del gioco affascinante ma impietoso della lega più bella del mondo; oppure che queste cose accadono ovunque, ma la cassa di risonanza della NBA amplifica l’onda d’urto della notizia, rendendola dirompente. Ma il nostro compito non è quello di liquidare, ma di dedurne uno spunto di riflessione più ampio.
Per certi versi, la decisione della franchigia d’oltreconfine è un paradigma, l’emblema di una tendenza ormai consolidata, di uno sport tanto diffuso, quanto di dubbio gusto: il tiro al piccione, laddove la figura del piccione è interpretata dai coach. Quest’anno, però, ad appena un mese dal termine della regular season, ha già mietuto vittime eccellenti: andando un po’ a memoria, hanno fatto le valige Hornacek a New York, Clifford a Charlotte, Van Gundy a Detroit, Vogel ad Orlando…E chiedo scusa se dimentico qualcuno, ma credo che già questi nomi siano sufficienti per incanalare il discorso nella direzione voluta: sono loro i responsabili dei fallimenti stagionali delle rispettive squadre? O non si tratta, piuttosto, dei più facili capri espiatori per una gestione societaria e di mercato non eccelsa? Pagano davvero, i coach, le loro colpe? E la pena è commisurata ad esse? Oppure cacciare loro serve a regalare un fremito di maligno piacere a qualche presunta all star insoddisfatta o ai tifosi assetati di sangue?
Ci esprimiamo metaforicamente, per fortuna: stiamo parlando di USA, un altro mondo e modo di intendere la passione sportiva…ci possiamo permettere l’uso di iperboli per enfatizzare i concetti.
Trovo stantia e puramente speculativa la discussione se il titolo di allenatore dell’anno fosse meritato o non andasse, piuttosto, assegnato a Stevens. Si sa che i premi vanno ai vincenti e Casey, in regular season, è arrivato al primo posto. Stevens si consola ampiamente con la finale di Conference ed ha l’età per vincerne dieci, di questi titoli. Casey ha cambiato il volto della sua squadra, trasformandola, dal nulla, da una bella incompiuta in una delle più intriganti realtà del mondo, sul piano del gioco e dei risultati, mettendo in fila tutti, vincendo meno della sola corazzata-Rockets e più di Golden State. Non scherziamo! Ha pagato un conto salatissimo alla rabbia del prescelto, probabilmente giunto all’ultimo assalto al cielo nella sua Cleveland; forse si poteva fare di più, forse si aspettava qualcosa di più dalle sue presunte stelle, senza le quali, è arcinoto, tanta strada ai playoff non la fai! Atlanta docet (coach Bud, però, è ancora lì al suo posto…).
La domanda che voglio porre, però, è un’altra: puntare a crescere ancora, oppure provare altre strade, a Toronto, sarà più facile con un coach differente? Permettetemi di dubitarne, alla luce di quanto visto in campo: una squadra mediamente talentuosa e fatta di isolamenti e sportellate sotto canestro, poco più, è divenuta una delle più temibili artiglierie e una delle più raffinate camaleonti della Lega; per distacco, la second unit più bella, profonda, efficace ed organizzata del panorama. Tutto in una stagione. Sbaglierò, ma, a mio modesto parere, la palma di allenatore del 2018 è meritata. Sbaglierò ancora, ma fossi un fan dei Raptors (e non lo sono), io il rischio di ricominciare da capo nella filosofia tecnica della squadra non me lo sarei preso; piuttosto, avrei messo Lowry e/o DeRozan di fronte alle proprie responsabilità. Ma magari è proprio così: mi sbaglio io.
Gli altri casi hanno, probabilmente, meno del clamoroso, ma due parole possono consolidare ed avvalorare il mio pensiero: Hornacek ha avuto a disposizione un progetto di squadra alquanto debole, tutto intorno all’unica star (Porzingis), cui ha dovuto rinunciare troppo presto ma, finché KP è stato al suo posto, se l’è giocata e spesso anche bene. In alcune occasioni ha mostrato sagacia, intelligenza tattica e buona reattività…Opinioni personali, certo, ma qualcuno avrebbe fatto meglio?
Clifford è uomo di provata esperienza ed è rimasto vittima di errori non suoi. Non sono l’unico a credere che Jordan non abbia, da presidente, esattamente la stessa stoffa che aveva da giocatore e che, in North Carolina, essere rimasti per tante stagioni nella più scomoda delle posizioni possibili in NBA, in quella specie di limbo che è la terra di mezzo tra l’ottava piazza e la zona-lottery, sia frutto non di incapacità tecnica, ma di ripetute scelte strategiche sbagliate. Ma chi volete che paghi, tra His Airness ed un Clifford qualsiasi?
Vogel era in una situazione più difficile da giudicare. Avrebbe dovuto guidare un rebuilding. C’era Gordon, c’era un Vucevic ritrovato e perfino migliorato (ma non lo si deve anche al coach?), ma il backcourt era all’altezza? E la panchina? A mio parere c’erano tutte le condizioni per poter pazientare ancora un paio d’anni e Vogel è giovane e capace, come già dimostrato altrove. Ma tant’è….
Van Gundy, forse, merita un discorso a parte: a Detroit lui non era solo coach, ma factotum, il deus ex machina delle cose tecniche ma anche di mercato. Al di là della spocchia del personaggio, le doti da coach sono innegabili. Ma qui, effettivamente, scelte errate ne sono state fatte parecchie, ed anche piuttosto cervellotiche: quest’anno le premesse per fare bene sembravano esserci tutte, da Drummond ad Harris, passando per il nuovo arrivato, Avery Bradley, giocatore di intelligenza e rilevanza tattica sottovalutate che sembrava potesse aiutare la franchigia del Michigan a fare il salto di qualità tanto atteso, per tornare in post-season con sufficiente credibilità. Ma poi la rivoluzione alla deadline, per portare a casa Griffin, si è risolta in una sconfitta per tutti: per il giocatore, per i Pistons e anche per i Clippers, oltre che in un’aperta sconfessione del progetto.
Il suo ruolo anche di GM, tuttavia, fa di SVG l’eccezione che conferma la regola: sono i manager a fare la squadra, sono i giocatori a scendere in campo ed a prendersi i meriti, sono i coach a pagare per tutti. Le scelte tecniche e la gestione di squadra e partita hanno il loro peso, ma nascono dal nulla ben di rado e sono, da sole, responsabili del fallimento di una stagione pressoché mai.
A New York hanno già scelto Fizdale per l’ennesima ripartenza: ottimo allenatore, auguri! Ma i precedenti nella Grande Mela, per gli allenatori di scuola-Memphis, non sono dei migliori (l’incubo-Hollins ancora aleggia su Brooklyn…). A Charlotte è stato appena chiamato Borrego, un rookie che si è fatto le ossa alla corte del Pop, per reggere la pressione e le genialate di MJ. Chapeau.
Se il cambio di manico sia in grado di produrre frutti e risolvere magicamente i limiti di una franchigia, probabilmente, non lo sapremo mai, perché troppi cofattori concorrono al risultato finale, e sarà sempre fonte di dibattito. Attendiamo le rivoluzioni di cui sopra alla prova dei fatti, ma il sospetto che si tratti di una formidabile epidemia di capri espiatori, dopo l’esonero di Dwayne Casey, è forte ed acre come l’odore di gomma bruciata. Auguriamoci che il fumo denso si disperda al più presto con la free agency e che non sia, invece, una cortina alzata ad arte per nascondere allo sguardo dei tifosi le lacune delle rispettive strategie societarie. A voi ed ai posteri, l’ardua sentenza.